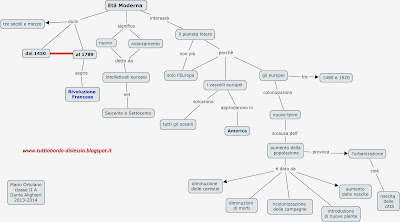Da Luca Passani riceviamo e volentieri pubblichiamo
Non sono un linguista di professione, ma, scrivendo per hobby, i temi linguistici mi hanno sempre appassionato, in particolare da quando mi sono reso conto di come esistano due modi antitetici di intendere lo studio di una lingua: bottom-up e top-down.
In breve, il modo bottom-up assegna alla lingua effettivamente usata dai parlanti l’ultima parola in fatto di correttezza, lasciando ai grammatici il compito di descriverla quella lingua, piuttosto che di normarla rigidamente. È l’approccio descrittivista.
Il modo top-down, invece, è quello dei grammatici puristi che si ergono a giudici di chi non rispetti le regole (incluso alcune pseudo regolette a volte) che credono di aver identificato dall’alto della loro infinita saggezza.
Avido lettore
Alcuni giorni fa mi sono trovato in una discussione Twitter in cui Licia Corbolante, una hobbista di tematiche linguistiche, se la prendeva con chi aveva tradotto avid birdwatcher come avido birdwatcher, argomentando che la parola “avido” in italiano non ha connotazione positiva.
Da linguista “laico”, ho osservato che in effetti la Treccani non riporta il significato di “avido” in italiano come “appassionato”, ma anche che l’espressione avido lettoreè usatissima in italiano, come può confermare autonomamente chiunque con una rapida ricerca su Google Libri:
La cosa mi ha stupito. Dal momento che una parola esiste ed è di uso comune, perché il dizionario Treccani non la riporta? Qual’è il ruolo dei vocabolari se non quello di documentare il significato dei vocaboli di una lingua? È possibile che tale accezione di avido venga avvertita come inglesismo e che, quindi (in osservanza del vento sovranista che tira in Italia negli ultimi tempi nei confronti di tutto ciò che è di origine inglese) la Treccani cincischi ad inserirlo sul suo vocabolario?
Ce n’era abbastanza per una domanda alla Treccani stessa:
Vedo spesso usata l'espressione "avido lettore" che appare come una traduzione letterale dell'inglese "avid reader". Una rapida verifica su Google Books conferma che l'uso è comune anche nei libri (https://bit.ly/3ek2kfU), quindi oramai l'espressione si è fatta strada anche nell'uso "dotto". Penso che sarebbe il caso di aggiornare il lemma "avido" sul vostro vocabolario per riportare anche quell'uso oramai standard (se poi sia il caso di metterci una noticina di stigmatizzazione, lo deciderete voi).
Alla domanda, il team della Treccani ha gentilmente rispostoalcuni giorni fa:
Una premessa: di solito nel Vocabolario Treccani.it le indicazioni prescrittive non prevedono “stigmatizzazioni”: il compito della lessicografia, a nostro avviso, è di documentare l’uso reale maggioritario condiviso, con indicazioni sui livelli e gli àmbiti d’uso aggiungendo eventuali suggerimenti circa opportunità, adeguatezza, efficacia.
Particolare cautela nel trattare i neologismi incipienti od occasionalismi interessanti (lessicali o semantici) viene messa per l’appunto nell’evitare messe al bando o censure: si lasciano i toni da crociata a chi interpreta la realtà, di cui la lingua fa parte, come campo di battaglia tra opposte schiere. Questo “chi” è molto ben rappresentato, non c’è bisogno che la Treccani entri nella zuffa. Nonostante ciò, il Vocabolario Treccani.it non si pone come arbitro sopra le parti: piuttosto, è una parte che cerca di documentare il tutto., segnalando particolarità e distinguendo quando ci sia da distinguere.
Nel caso di avido ‘bramoso, desideroso’, usato sia assolutamente (un avido lettore) sia come introduttore argomentale (avido di conoscere la natura, avido di novità), sembra di poter dire che può esercitare qualche influsso anche la presenza di avid nelle traduzioni dall’inglese di testi non letterari, bensì giornalistici o d’occasione presenti in internet. Come nota Licia Corbolante, avid non ha una connotazione intensiva e negativa come avido ha in certi usi in italiano (avido di ricchezza, di potere, di lusso) e ciò può portare a qualche ricalco improprio nella nostra lingua, creando confusione. Peraltro, un avido lettore si può dire già in italiano da tempo, senza per forza scomodare l’idea che questo avido ricalchi meccanicamente la semantica di avid in inglese.
Sono grato alla Treccani per avermi risposto, ma la risposta continua a lasciarmi perplesso per parecchi motivi.
● “[I]l compito della lessicografia, a nostro avviso, è di documentare l’uso reale maggioritario condiviso”.
Prima perplessità: e un uso condiviso ma minoritario allora un vocabolario non lo deve documentare? Allora possiamo cominciare a togliere il “sé stesso” accentato tanto caro ad alcuni ma ridicolosamente minoritario?
● Parlare di “neologismi incipienti od occasionalismi interessanti (lessicali o semantici)” significa ignorare la mia osservazione che l’espressione sia usatissima con quella accezione non solo nei giornali, ma anche nei libri, e quindi è, per definizione, un uso italiano (e non un neologismo incipiente né un occasionalismo usato solo dai giornali).
● Viene rivendicato il ruolo della Treccani nel documentare e segnalare. Perfetto: e allora perché avido non è documentato/segnalato con il significato di “appassionato”?
● Vedo contraddizione dove prima si riconosce che avid=bramoso risente dell’inglese (riferimento alla Corbante), per poi dire che si può arrivare a quel risultato “senza per forza scomodare l’idea che questo avido ricalchi meccanicamente la semantica di avid in inglese”.
Forse sono scemo io, ma non ho capito: avido lettoreè un calco meccanico dell’inglese oppure no? E anche se fosse dimostrato che è un calco (ancora non si sa), perché dovrebbe essere escluso dal vocabolario visto che è usatissimo?
Insomma, forse sarebbe il caso che qualcuno spiegasse a un non professionista qual’è il ruolo dei vocabolari, perché, al momento, mica l’ho capito.Forse sono scemo io, ma non ho capito: avido lettoreè un calco meccanico dell’inglese oppure no? E anche se fosse dimostrato che è un calco (ancora non si sa), perché dovrebbe essere escluso dal vocabolario visto che è usatissimo?